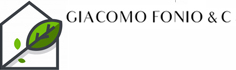Abitazione principale senza avere la residenza

Si può avere la residenza in un posto e l’abitazione principale in un altro? Secondo il parere della Cassazione, espresso in una recente ordinanza, sì. Il perché, secondo la Suprema Corte, è subito spiegato: è possibile considerare un immobile ai fini fiscali abitazione principale senza avere la residenza quando i consumi delle utenze dimostrano dove effettivamente vive il contribuente.
Questo pronunciamento appare molto interessante perché, da una parte, cambia le carte in tavola rispetto alla definizione di abitazione principale data dal ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale vanno versate o non versate certe tasse in base al fatto che un’unità immobiliare sia abitazione principale o meno. Dall’altra, apre uno scenario particolare per il cittadino proprio sul fronte fiscale: su quale delle due case deve pagare l’Imu? Sull’abitazione in cui ha la residenza o su quella che figura come abitazione principale senza la residenza?
Vediamo, a questo punto, che cosa dice la legge e quale novità introduce l’ordinanza della Cassazione rispetto alla possibilità di ritenere una casa abitazione principale senza avere la residenza.
Abitazione principale: che cos’è?
Visti i risvolti fiscali dell’ordinanza della Cassazione in commento, vediamo che cosa intende il ministero dell’Economia e delle Finanze per abitazione principale. La definisce «come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente» [2].
Sempre il Mef precisa che sono assimilate per legge all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con qualche eccezione, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Dal 2020, invece, non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Tali assimilazioni, precisa ancora il Ministero, «non possono essere modificate dai Comuni. Gli enti locali, però, possono prevedere nel proprio regolamento l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse».
Abitazione principale senza residenza: quando è possibile?
Secondo la recente ordinanza della Cassazione, può essere considerata ai fini fiscali come abitazione principale la casa in cui il contribuente non ha stabilito la sua residenza ma nella quale i consumi delle utenze domestiche sono elevati. Questo, per forza di cose, ha delle conseguenze sull’esenzione Imu.
Va ricordato che l’imposta sugli immobili non è dovuta per l’abitazione principale, tranne per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero per le abitazioni di lusso. Non è dovuta nemmeno su una pertinenza per ogni categoria (C/2, C/6 e C/7, ovvero box auto, cantina, ecc.), anche se non fisicamente collegata all’unità immobiliare.
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, se un contribuente dimostra con le bollette che vive abitualmente in una casa in cui non ha la residenza, tale immobile può essere considerato ai fini fiscali come abitazione principale. L’Imu, a questo punto, verrà pagata sulla casa in cui ha la residenza ma non figura come abitazione principale, poiché – ricordano o giudici di legittimità – l’agevolazione prevista non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato dal contribuente e la sua residenza anagrafica.
Nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, il cittadino ha dimostrato il requisito richiesto per la detrazione attraverso le bollette delle utenze domestiche, la partecipazione alle assemblee di condominio e le ricevute di pagamento delle spese condominiali.
(Articolo letto su la Legge per tutti)